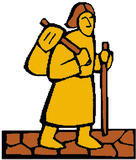
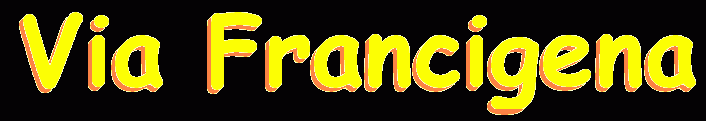
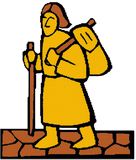
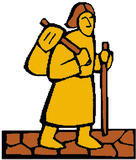
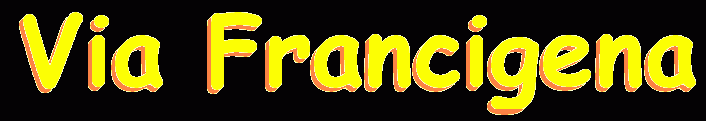
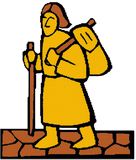
la VIA
FRANCIGENA ieri e oggi: un itinerario culturale europeo
La
Francigena è storicamente una delle più importanti vie di comunicazione che
dal Medioevo in
poi venivano percorse per portare i pellegrini (naturalmente non solo loro ma
anche i comuni viaggiatori, i mercanti, i diffusori di scienza e conoscenza, i
ciarlatani, gli avventurieri, i prelati, i peccatori in cerca di espiazione e,
naturalmente, i soldati) nei centri più importanti
dell'Europa: Gerusalemme in Terra Santa, Santiago di Compostela in Spagna e
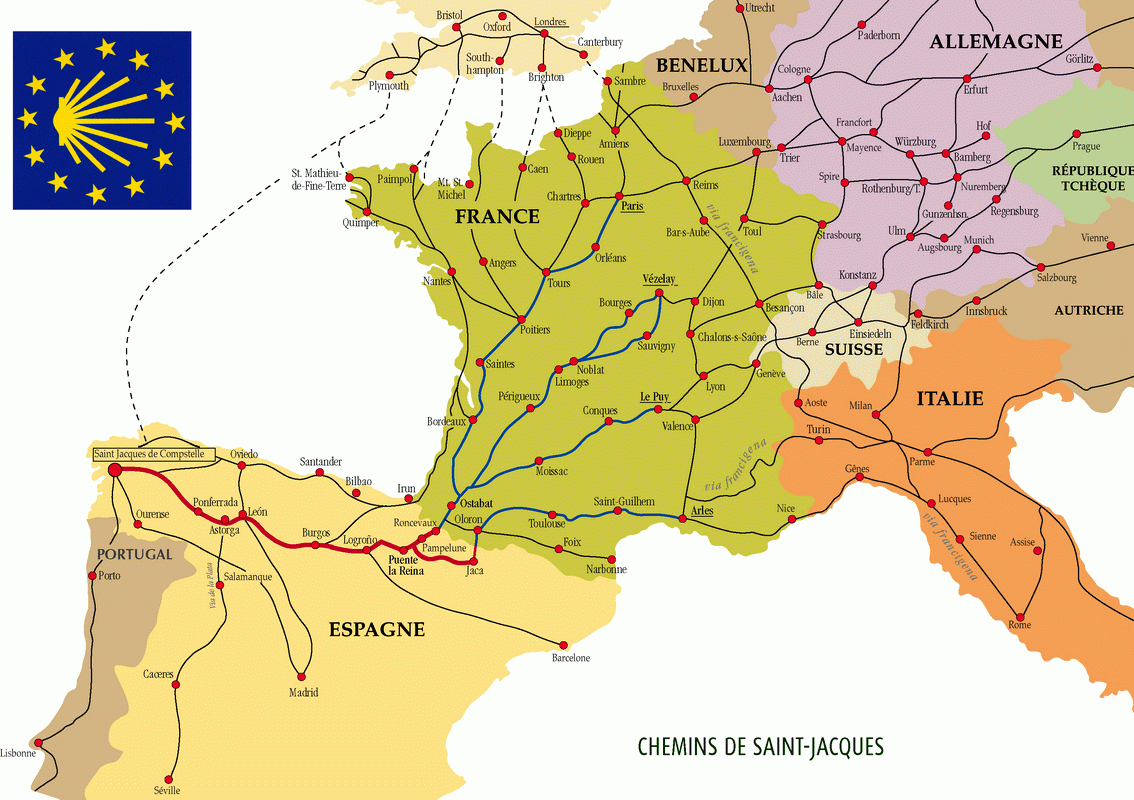 Roma
in Italia erano poi privilegiate in quanto le tre più significative mete
religiose della Cristianità.
Roma
in Italia erano poi privilegiate in quanto le tre più significative mete
religiose della Cristianità.
La palma, la conchiglia e le chiavi di Pietro e
erano rispettivamente i simboli di questi tre pellegrinaggi: "chiamansi
palmieri in quanto vanno oltremare, là onde molte volte recano la palma;
chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di Galizia, però che la sepultura
di sa’ Iacopo fue più lontana de la sua patria che d’alcuno altro apostolo;
chiamansi romei in quanto vanno a Roma...", secondo la definizione di Dante
nel cap. XL della Vita Nuova.
La Via Francigena, l'asse che univa Canterbury e la Francia centro-settentrionale a Roma, intersecava quella proveniente da Santiago e dalla Francia meridionale e quella da Brema e dal mondo germanico; da Roma, infine, conosciuta anche col nome di Francigena del Sud riprendeva il cammino fino ai porti della Puglia, dove ci si imbarcava per la Terrasanta.
Erano viaggi che duravano mesi, se non anni; pieni di disagi e pericoli anche nei (rari) momenti di pace, si trattava di peregrinazioni dalle quali poteva accadere di non ritornare: strade inadeguate, tempeste, agguati, malattie, fame, briganti... erano inconvenienti tutt'altro che eccezionali. Rispetto a quelli di allora anche i più spartani e avventurosi dei viaggi d'oggi sono una gita parrocchiale.
Tuttavia sapere di posare i piedi su un acciottolato calpestato un tempo da un
soldato romano o da un viandante medioevale, oppure raggiungere a fatica un
crinale e vedersi spalancare davanti agli occhi uno scenario di colline
tondeggianti, vallate e boschi incontaminati (almeno in apparenza) dalla presenza dell'uomo moderno,
o avere come
unico compagno di viaggio lo scricchiolio delle foglie sotto i propri piedi o la
carezza del vento su un mare di grano ancora verde, tutto questo ha un suo innegabile fascino che
nessuna rapidità di viaggio può lontanamente compensare: da una media distanza
come Livorno, percorrendo su asfalto e in pianura le vie più dirette e
scorrevoli si potrebbe
raggiungere Roma in poco tempo:
poche ore in auto o due giorni in bici da corsa, mentre utilizzando vie secondarie
e collinari, strade bianche o sentieri tra i campi, il percorso diventa più lungo e più lento: almeno quattro
giorni in bici e due settimane a piedi. Ma, se non si ha fretta -e il senso del
viaggio sta nel viaggio stesso più che nella meta- il maggior tempo impiegato è un
costo irrisor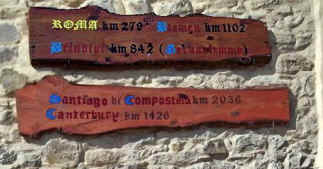 io rispetto a ciò che si guadagna.
io rispetto a ciò che si guadagna.
Il nome di Francigena o Francesca le derivava dall'essere la Via dei Franchi (in quanto abitanti del Nord Europa e non necessariamente della Francia), ma era denominata anche Via del Monte Bardone (da Mons Langobardorum, cioè dei Longobardi, i quali, per recarsi dal Nord ai loro ducati nell'Italia meridionale, la preferivano alle vie costiere controllate dai Bizantini, loro ostili), corrispondente all'odierno passo della Cisa.
Il
primo viandante ad averci dato testimonianza di questo percorso, fu Sigerico,
un arcivescovo
inglese che lo affrontò intorno al 990 d.C., lasciandoci un diario di viaggio
nel quale descrive puntualmente ogni mansio, o tappa, delle 79 che
costituirono il suo viaggio di ritorno a Canterbury da Roma, dove aveva ricevuto
dal Papa l'investitura arcivescovile. Dopo di lui un altro religioso, l'abate
islandese Nikulás Bergsson, nel XII secolo, percorse la Francigena da Munkaþvera fino
a Roma (per poi proseguire fino a Gerusalemme); nel suo
resoconto, ancor più dettagliato, sono presenti utili informazioni anche sui
luoghi attraversati e sulle varianti del percorso. E poi, ancora Matilde di
Canossa, Filippo II Augusto di ritorno dalla terza Crociata,
Carlo d’Angiò e altri ancora. Da allora centinaia di
migliaia di pellegrini hanno percorso tutta o in parte quella rete di cammini
per giungere ad limina Petri. E di conseguenza, stimolando la creazione
di Spedali e Chiese, mercati e punti di sosta o ristoro, ponti e strade,
Confraternite e associazioni, hanno contribuito allo sviluppo di tanti centri
urbani; ma soprattutto hanno favorito i contatti tra i popoli e gli scambi di
prodotti agricoli, manufatti, opere d'arte, ma anche idee, gettando così
le basi per la futura consapevolezza di appartenenza alla civiltà europea:
"L'Europa si è costruita nei  pellegrinaggi",
diceva Goethe.
pellegrinaggi",
diceva Goethe.
Dell'antico
cammino della VF oggi non rimane molto: da un lato le frane e le alluvioni, o le
guerre, che con le pestilenze o le carestie hanno portato all'abbandono di
alcune strade e di centri abitati, dall'altro il
succedersi e l'ampliarsi delle coltivazioni, la deforestazione, l'espandersi o il sovrapporsi delle
urbanizzazioni, da un altro ancora lo sviluppo dirompente di nuove vie di comunicazione e di nuovi
mezzi che hanno reso obsoleta la figura del viaggiatore a piedi, in una parola,
i secoli, hanno sopraffatto o celato gli antichi tracciati.
Però non tutto è andato perduto, anche perché oltre alle tracce ancora visibili,
altre ne sono state ricercate e ritrovate, ma soprattutto è stato
recuperato l'interesse per questo tratto di storia nella quale affonda le
origini il sogno stesso di unità europea, tanto che nel 1994 l' U.E. ha dichiarato la Via Francigena "Itinerario Culturale del Consiglio
d'Europa".
Al tempo stesso, sulla scia di quanto già accaduto per il Cammino di Santiago, è
risorta l'attenzione
verso modalità di viaggio un tempo tradizionali
come quella di spostarsi a piedi o a cavallo, alle quali si è aggiunta
recentemente la bicicletta, il mezzo ideale per un "viaggio lento",
capace di far ammirare gli stessi capolavori della natura e dell'uomo fruibili
dai viandanti, ma in tempi non eccessivamente dilatati. Le amministrazioni regionali e
locali, mosse anche dalla prospettiva -grazie al turismo pellegrino- di un
ritorno economico in aree non sempre floride, hanno saputo valorizzare le molteplici
opportunità che la riscoperta della Via Francigena offriva e con la
collaborazione di enti religiosi (parrocchie, conventi, confraternite etc.), di
associazioni laiche e di numerosi volontari, hanno individuato e restaurato
tracciati, predisposto le opportune segnaletiche, allestito punti di accoglienza
o ristoro, creato un'ampia rete informativa disponibile anche sul web,
sensibilizzato la popolazione locale e pubblicizzato in vario modo ogni
iniziativa, tanto che
oggi non si contano le associazioni istituzionali e non, i siti internet, i
libri, le riviste specializzate, i diari di viaggio, le varie manifestazioni
culturali e i festival dedicati alla Francigena.
specializzate, i diari di viaggio, le varie manifestazioni
culturali e i festival dedicati alla Francigena.
Dei circa 1800 km che uniscono l'abbazia di Canterbury a Piazza S. Pietro a Roma, oltre 900 si trovano in Italia e per una volta l'Italia non è rimasta indietro rispetto alle altre nazioni europee, dato che il tratto italiano è quello, al momento, che garantisce una maggiore completezza e una migliore organizzazione, con punte d'eccellenza in alcune regioni, una per tutte, la Toscana. Partendo dal valico del Gran San Bernardo il percorso si snoda dalla Val d'Aosta all'Emilia, passando tra l'altro da Aosta, Vercelli, Pavia, Piacenza, Fornovo; superato il Passo della Cisa, entra in Toscana toccando Pontremoli, Aulla, Lucca, Altopascio, San Gimignano; si affianca alla Cassia presso Siena; dopo San Quirico d'Orcia entra nel Lazio ad Acquapendente, raggiunge Bolsena, Viterbo, Sutri e finalmente Roma.
E' in uno stadio di avanzata realizzazione, infine, anche la Francigena del Sud: ripartendo dal soglio di Pietro, questo tratto è destinato a ripercorrere quasi un millennio dopo gli stessi passi che i pellegrini muovevano verso il Meridione, per raggiungere la Palestina e Gerusalemme via mare, dai porti pugliesi di Bari, Brindisi, Otranto o S. Maria di Leuca. Inoltre questo tratto meridionale della Francigena si sdoppia nel beneventano tra l'Appia Antica (che raggiunge Venosa e Taranto) e l'Appia Traiana (che da Troia raggiunge Bari e la costa Adriatica) e interseca all'altezza di Troia un'altra via di pellegrinaggio, quella dedicata all'arcangelo Michele, ovvero via Micaelica, che collegando con Roma il santuario di S. Michele in Cornovaglia e Mont Saint Michel in Normandia, si concludeva a Monte S. Angelo sul Gargano.
In verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un
viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando. Per
questo l’uomo deve poter viaggiare.
(Andrej Tarkowsky)